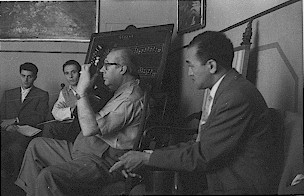i |
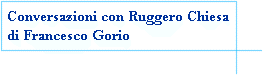 |
||
| 1
2 3 4
5 |
|||
D. Tra le tue revisioni di musica per chitarra con altri strumenti, quali ricordi con più piacere?R. Sono un convinto assertore della necessità di conoscere e diffondere la musica da camera con chitarra. Questo perché il repertorio è molto bello, e perché può offrire una buona possibilità di lavoro. Sono quindi soddisfatto di aver pubblicato alcuni lavori importanti, come i Sei Quintetti di Boccherini conservati manoscritti nella Library of Congress di Washington, e di aver contribuito alla rivalutazione di autori come Gragnani. In particolare sono contento di certe mie iniziative, come la pubblicazione dei tre Concerti di Giuliani nella versione integrale. Sembrava un'operazione destinata al fallimento, per l'inerzia e l'ottusità di gran parte del mondo chitarristico, ma ora ci si sta accorgendo quanto siano importanti questi bellissimi concerti. D. Prima di intraprendere la professione musicale, cosa facevi?R. Da ragazzo, dopo le scuole medie, ho frequentato l'Istituto Nautico a Camogli. Ero suggestionato dalla lettura di libri d'avventura, come quelli del Salgari, e la vita di mare mi sembrava ancora circondata di mistero. Terminati gli studi, mi sono reso conto che la situazione era alquanto diversa, ma nel frattempo mi ero avvicinato alla chitarra, e avevo già compiuto la scelta della mia vita. D La tua formazione culturale extramusicale, a cosa fa riferimento?R. ...Leggevo anche molto per conto mio, pur se non sono mai riuscito a possedere una cultura di tipo enciclopedico. Accanto alla razionalità avevo bisogno dello sfogo fantastico. Questo dualismo mi ha portato spesso fuori della realtà, spingendomi a volte ad intraprendere azioni che potevano essere logicamente sconsigliabili. Quando da Camogli sono giunto a Milano, con la mentalità dell'emigrante che cercava fortuna, non mi rendevo conto delle gravi difficoltà che dovevo superare, perché ero tutto compreso a seguire le mie immaginazioni, e ogni cosa mi sembrava possibile. Non riesco ancora a capire se in tutto ciò che è successo in seguito ha giocato soltanto la fortuna, o se sono riuscito a sfruttare al meglio le mie nozioni musicali. Ho avuto certamente più di quanto meritavo. D. Al di fuori dell'esperienza chitarristica, quali studi musicali hai seguito?R. ...Il primo, il pianista, studiava anche armonia per corrispondenza, seguendo un metodo ideato da un professore del Conservatorio di Firenze... Incuriosito da quell'esperienza, mi iscrissi al corso, acquistando le dispense fornite dall'intraprendente maestro, e cominciai i contatti epistolari, che consistevano nell'inviare i compiti di armonia e nel riceverli con correzioni e commenti. Queste sono state le mie basi musicali, e devo dire che, se si considera l'isolamento in cui vivevo come persona e come chitarrista, ho avuto una buona intuizione. Anche se a volte mi perdevo in un bicchier d'acqua, mancando il contatto diretto con il maestro, le basi fondamentali dell'armonia le devo proprio a quell'insegnamento un po' fuori dal comune. Per realizzare i compiti avevo anche bisogno del pianoforte, che ricevetti come regalo da uno zio. Così, in un'epoca che vedeva spesso i chitarristi tagliati fuori dall'istruzione musicale, mi sono trovato nelle condizioni di analizzare, quasi dall'inizio, i pezzi che suonavo. Forte di queste cognizioni, e convinto che la letteratura originale per chitarra fosse insignificante, trascrivevo tutte le opere per pianoforte o per violino che mi capitavano a tiro. Era un lavoro piuttosto ingenuo - altri lo avevano fatto prima e meglio di me - ma mi è servito moltissimo per conoscere lo strumento. ... In seguito ho ricevuto alcune lezioni di armonia e di contrappunto da Mario Barbieri, un compositore che viveva a Genova, e che ha scritto anche pezzi per chitarra. Fu un contatto breve, poi ho proseguito gli studi come autodidatta. D. Dopo questa analisi della chitarra nel mondo, quali sono le tue considerazioni riassuntive?R. Anche se non ho parlato ancora dell'Italia, si potrebbe fare una diagnosi che vale per tutti i paesi. Dopo la figura di Segovia, che ha dominato incontrastata per lungo tempo, circa venticinque anni fa si è imposta una generazione di esecutori, in parte proveniente dai suoi insegnamenti, che ha avuto come nomi di spicco Yepes,
Tutte queste persone hanno formato, e stanno formando oggi, tramite la loro azione
diretta e indiretta, i giovani chitarristi dell'ultima generazione. Per il vuoto dovuto
alle ragioni storiche che conosciamo, la diffusione capillare della chitarra è quindi
iniziata verso il 1950. Prima, pur con eccezioni "storiche", il nostro strumento
veniva suonato quasi esclusivamente nel genere popolare e leggero. La situazione attuale
della chitarra è la risultante di tutte queste componenti. Come primo dato di fatto
certo, forse l'unico che ci può trovare tutti d'accordo, possiamo porre l'elevato
sviluppo della tecnica strumentale, anche se ancora lontano dall'aver raggiunto i suoi
vertici. Questo significa che, malgrado l'esistenza di princìpi didattici diversi, tanti
chitarristi sanno muovere meglio le mani rispetto a ciò che avveniva in tempi ancora
recenti. Gli esecutori possono così cimentarsi, molto spesso, con brani la cui
interpretazione era, negli anni Cinquanta e Sessanta privilegio di pochi. Le scelte di
repertorio, sempre nell'ambito di coloro che si definiscono "chitarristi
classici", sono invece assai diverse. Non è raro ascoltare, nei programmi
concertistici, musica di alto valore alternata ad altra di peso insignificante. In genere,
questi tipi di programmi sono eseguiti magari con buona o ottima preparazione strumentale,
ma con insufficiente maturità musicale. È infatti improbabile che un chitarrista,
voglioso di suonare in concerto pezzi di dubbio gusto, per solleticare il palato più
spesso della platea, riesca, nella stessa occasione, a cogliere una grande interpretazione
di Bach o di altro autore rappresentativo. Un programma intelligente, che sappia
illustrare le migliori caratteristiche della storia della chitarra, è oggi abbastanza
raro, e ancor più è difficile ascoltarlo ad alto livello. Il chitarrista in genere, è
più interessato all'effetto strumentale di una composizione, piuttosto che al suo valore
assoluto musicale. Nello stesso tempo, diffidando, per mancanza di cultura, del proprio
repertorio originale di maggior valore, si cimenta allegramente in trascrizioni di brani
celebri, spesso maldestre, nel tentativo patetico di dimostrare che la chitarra
"avrebbe potuto" essere un grande strumento, se per essa fossero state scritte
opere con grandi firme. Questa mentalità è ancora oggi molto frequente, e il revival
delle trascrizioni sta a provare che il chitarrista piagnucolante per il suo amaro
destino, che alza gli occhi al cielo quando ascolta Beethoven, vergognandosi di avere
soltanto un Giuliani, è oggi più vispo che mai. Accanto tipo di esecutore, che suona
male Sor ma che vuol farsi bello con Mozart, esistono piccoli gruppi di persone, sparse
nelle diverse nazioni, soddisfatte del loro strumento e della sua musica - certo sarebbe
stato bello avere uno Schumann chitarrista, ma se si sente tanto la mancanza dei
grandissimi compositori, perché studiare la chitarra? - le quali si adoperano per
studiare, analizzare, scoprire e interpretare il repertorio originale. Io sono fermamente
convinto che affidare il destino della chitarra alle trascrizioni che vanno da
Frescobaldi, a Haendel, a Mozart, per giungere ai Capricci di Paganini, sia un'operazione
alla lunga fallimentare. Certo ci sono alcuni virtuosi che costruiscono la loro fortuna
con programmi funambolici, dove si mettono in risalto le loro indubbie doti, ma questi
personaggi si farebbero strada comunque. Qui non si tratta di disconoscere le capacità
dei singoli, ma di stabilire su quali presupposti si fonda la credibilità di uno
strumento. Ebbene, non esiste nella storia della musica nessuno strumento che abbia
lasciato una traccia senza una consistente letteratura originale. L'angelica, la tromba
marina, il baryton o la più recente fisarmonica sono certamente strumenti ricchi di
qualità, ma non si può dire che essi abbiano oggi un peso rilevante. Se però avessero
avuto la costante attenzione dei compositori per quattro secoli, le cose sarebbero
diverse. La chitarra possiede questa fortuna - volendo escludere i modelli rinascimentali
e barocchi, rimangono ben duecento anni - ma sono proprio tanti chitarristi che lo
dimenticano.
D. Quale differenza pratica esiste tra questi due metodi di trascrizione?R. In sostanza nessuna, perché la realizzazione dei valori musicali avviene nello stesso modo in ambedue i sistemi, ma su due righi si legge la reale altezza dei suoni, e su un rigo il trasporto all'ottava bassa, come per la chitarra. Inoltre, il doppio sistema considera il liuto rinascimentale accordato in Sol, che corrisponde al modello ormai usato da tutti, mentre nel sistema semplice l'accordatura del liuto è in Mi, simile a quella della chitarra. D. Questi sono stati i motivi che ti hanno condotto a rallentare le tue indagini sulla musica antica?R. In parte. Per me era assolutamente indifferente passare alla trascrizione su due righi. I veri motivi sono stati altri. Pur continuando a interessarmi di musica antica, come testimonia la "Storia della letteratura del liuto" che appare su ogni numero del "Fronimo", mi sono accorto, tramite ricerche che compievo sulle fonti della letteratura chitarristica, che il repertorio originale del nostro strumento, scritto tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, era vastissimo e di grande qualità, contrariamente a ciò che pensavano gli stessi chitarristi. La mia diffidenza per le nostre opere classiche, di cui avevo sentito il contagio a causa delle prevenzioni che dilagavano nel nostro ambiente, spariva rapidamente mentre scoprivo tante bellissime composizioni. A quel punto la mia attività editoriale si è rivolta alla scoperta e alla diffusione del miglior repertorio originale scritto nell'epoca classica e romantica, non dimenticando però di avvicinare alla chitarra anche i compositori contemporanei. D. Quali reazioni ci sono state nell'ambiente chitarristico negli anni in cui hai fatto conoscere le prime opere classiche?R. I miei lavori di musica antica sul liuto e la vihuela avevano incontrato un certo favore, ma quando ho pubblicato le prime opere non didattiche dei maestri dell'Ottocento, come Giuliani, non tutti i chitarristi si sono trovati d'accordo nel condividere i miei giudizi positivi su quella musica. Abituati da anni a conoscere e a suonare soltanto pochi brani della letteratura classica – non si andava più in là dalle Variazioni op. 9 e del Gran Solo di Sor, e del primo tempo della Sonata op. 15 di Giuliani – gli esecutori erano convinti che il repertorio concertistico di quell'epoca fosse inconsistente. D. Come si era giunti a questo giudizio?R. una storia lunga. Tutto è cominciato con il tramonto della scuola classica , verso la prima metà dell'Ottocento, e dalla responsabilità di Tárrega, l'unico chitarrista del secolo scorso che avrebbe potuto e dovuto tener viva la nostra tradizione. Tárrega, invece, in parte per carenza culturale, in parte per ambizione, eliminò nei suoi programmi concertistici ogni composizione dei maestri che lo avevano preceduto, inserendovi trascrizioni di autori famosi, e sue proprie opere. In questo modo egli riusciva a dimostrare certe qualità polifoniche ed espressive del suo strumento facendo ascoltare pezzi celebri scritti per pianoforte, violino, e così via, mentre nello stesso tempo appariva l'unico compositore di rilievo per la chitarra. Le doti non gli mancavano, e il gioco riuscì: Tárrega uguale chitarra, e chitarra uguale Tárrega; tutto cominciava con lui. Dopo la sua morte, poiché la chitarra classica si suonava quasi esclusivamente in Spagna, l'equivoco si è perpetuato, con il valido aiuto di alcuni suoi allievi, come Pascual Roch, ma soprattutto Pujol, i quali convinsero tutto il mondo che il primo vero grande chitarrista della storia, nel concertismo, nella didattica e nella composizione era stato Tárrega. A nulla valse l'acuto giudizio che Domingo Prat diede su di lui nel Diccionario de guitarristas, pubblicato nel 1937, dove la sua figura era posta nei giusti limiti, e dove si riconosceva ad altri, come a Sor, il merito di essere stati i veri grandi compositori. Ormai l'analisi storica era completamente falsata, e per anni nulla sarebbe cambiato. D. Anche Segovia condivideva queste opinioni?R. Segovia riconosceva che tutti i chitarristi della sua generazione dovevano qualcosa a Tárrega, ma non lo esaltava di certo come compositore. Piuttosto, era convinto che la letteratura originale dell'Ottocento avesse poco peso. Rispettava soltanto Sor, anche se suonava raramente le sue opere, e in un suo commento lo definiva "un poco flojillo". D. Tra i brani per chitarra sola che hai pubblicato, quale ti è più caro?R. Ogni volta che mi accingo a compiere una revisione sono sempre convinto e entusiasta della musica che ho scelto, anche se comprendo la diversità di valore che può esistere tra una composizione e un'altra. Ricordo con piacere le prime pubblicazioni di musica dell'Ottocento, perché ero convinto di intraprendere una strada giusta. Certi miei colleghi mi rimproveravano di far rivivere opere che, secondo loro, dovevano rimanere nel cassetto, ma i fatti hanno dimostrato che erano essi a non capire. Quando ho pubblicato le Variazioni op. 38 di Giuliani, una di queste menti acute mi ha telefonato per esprimermi la sua disapprovazione, dimenticando che i suoi programmi erano infarciti di allegre musichette sudamericane. Era l'espressione di una mentalità molto diffusa alcuni anni fa, e oggi tutt'altro che sparita. Sono anche soddisfatto di essere riuscito a convincere molti compositori contemporanei a scrivere per la chitarra. Ho avuto l'opportunità di conoscere personalmente tanti musicisti italiani, e ho sempre chiesto a ciascuno di loro almeno un pezzo per il nostro strumento. Purtroppo non tutti l'hanno fatto, ma non dispero che ciò possa avvenire in futuro. |
|||